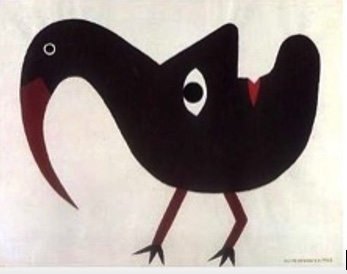Politiche dell’altrimenti come linee di fuga

Il nuovo tour italiano di Báyò Akómoláfé
sarà un festival para-pedagogico, una libagione nelle crepe, una pragmatica dell’inutile, una opportunità per pensare insieme politiche dell’altrimenti anche là dove ogni linea di fuga sembrerebbe preclusa…
Un festival itinerante con 4 tappe – 1 febbraio: Black History Month a Torino, 2 febbraio: Uni Bicocca a Milano, 3 febbraio: Scuola Etno-sistemico-narrativa a Roma, 4 febbraio: Terzo Paesaggio a Milano
Ogni incontro una variazione sul tema per declinare un’ecologia delle pratiche e per ricordare cosa possa significare “casa” fuori dall’illibertà sovrana mentre piangiamo e ridiamo con i nostri parenti umani e non umani in questa terra desolata.
La preposizione greca παρά ha molti significati: simile, oltre, al di là, contro. Come prefisso para- è spesso usato come contrappunto al significato consolidato di una parola, di una pratica, di una disciplina. Come in paramedico (qualcosa che si aggiunge ma non sostituisce la medicina) paranormale (decisamente al di là del normale) paradossale (contrario all’opinione comune). Il para-pedagogico si riferisce ai contesti, ai paesaggi percettivi, alle dimensioni relazionali che aprono a un pensiero nel-mentre, a un pensiero in fuga, a un pensiero emergente sempre a partire da pratiche che attraversano i corpi e le menti al di là dei confini e delle categorie date.
Dettagli
1 febbraio Torino

Due eventi : Bayo inaugura il BHM di Torino alle 16.30 al Museo Reale in piazzetta Relae 1, con una conversazione che intreccia la riflessione su quali eredità e quali appartenenze lasceremo a figli e nipoti con il tema della nerezza come risorsa transrazziale, riccheza eccedente le architetture della modernità coloniale.
Alle 20.30 alla libreria Trebisonda via Sant’Anselmo 32 rprenderemo la conversazione con la presetazionedi “Queste terre selvagge oltre lo steccato” coadiuvati dalle lettura di Vesna Scepanovic
Non sono necessarie prenotazioni
2 febbraio Milano
Ore 14 Università Bicocca edificio U6 IV piano stanza 4152
Per le Bell Hooks lectures del Dipartimento per le scienze umane della formazione conversaziione aperta, non è necessario iscriversi
Pensieri diasporici

La storia della schiavitú è ricca di lezioni di resistenza, creolizzazione e fuga dall’ingiustizia – dai quilombo brasiliani all’undeground railroad
La “nerezza” (blackness) prima ancora che un paradigma identitario è sempre stata un eccesso relazionale che la neuro-tipicità coloniale non è mai riuscita a domare. Ma che fare quando non c’è via di fuga, quando le geopolitiche e la violenza di stati e imperi normalizano la distruzione e si rifiutano di disarmare il lutto? Come aggiornare le lezioni della “nerezza” immaginando un’ecologia di pratiche senza cedere a facili politiche identitarie né accettare l‘anestesia delle coscienze?
Come prendere posizione trovando linee di fuga da un’architettura sociale in cui le crepe diventano sempre più evidenti?
<https://www.facebook.com/events/941883860637038/>
Possibile accedere on line al link https://unimib.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/unimib/meeting/download/606958E16DDCD506E0531AA2FD0AFEBA
3 febbraio Roma Roma dalle 10 alle 18 via Cesare Balbo 4 a

«Il feticcio supremo della modernità è forse la nozione di individuo. Avulso da relazioni ecologiche, pixelato all’interno di uno spaziosensoriale e cognitivo funzionale ai ritmi imposti da una forma di economia divorante e cieca. Ma il feticcio non funziona più e lesoluzioni proposte continuano a far parte del problema. La salute non può fondarsi sul diniego dell’intreccio ferito con un pianetavivente, né l’idea di cura ridursi alla ricerca di rimedi palliativi per la crisi di una modernità che nessuna “soluzione finale” può“guarire” con una delirante formattazione di ciò che dev’essere normalizzato.»
È invece nelle crepe della crisi che qualcosa di diverso può emergere.
Aggiungendo il prefisso ab (che indica il muoversi “da”) Báyò Akómoláfé propone un pensiero “in fuga” dallapsicologia adattiva verso ecologie della salute e della cura in continua tensione verso un “altrimenti” fertile e animato.
La sessione mattutina proporrà un workshop esperienziale, quella pomeridiana elementi di riflessione e confronto.
E’ necessario iscriversi scrivendo a info@etnopsi.it (Tel.) +39 3317149736
Il seminario ha un costo di 80€ (50€ per ex alliev* e partecipanti al gruppo “Clinica della crisi”).
Alcune borse di studio sono disponibili per facilitare l’accesso a persone fortemente motivate ma impossibilitatea seguire la giornata seminariale per difficoltà economiche.
I
Infine 4 febbraio Milano, Terzo Paesaggio, Padiglione Chiaravale, via San Bernardo 17
dalle 11 alle 17
Per un’ecologia delle pratiche
(piccolo festival para-pedagogico)

Una intera giornata di piccole sperimentazioni e conversazioni per imparare e disimparare insieme. Terzo Paesaggio e Clinica della Crisi sono felici di ospitare nuovamente Báyò Akómoláfé a Chiaravalle.
E’ necessario iscriversi a questo link:
A seguire alle 18 incontro ristretto per Clinica della Crisi, Vunja! e per chi ha seguito Bayo nelle varie tappe di questo e del suo tour precedente. Chi è interessato a quest’ultimo evento mi scriva a fabrice.olivier.dubosc@gmail.com
Báyò Akómoláfé intreccia il pensiero critico contemporaneo con le intuizioni della tradizione Yoruba. Pur avendoprivilegiato la libertà del pensiero nomade alla carriera universitaria è in dialogo continuo con gli ambiti di ricerca più creativi in molteplici contesti. Ha fondato The Emergence Network. Nel 2022, è stato nominatoprimo Global Senior Fellow (o “provocatore residente”) dell’Othering and Belonging Institutedell’Università di Berkeley (California). In italiano è uscito il suo “Queste terre selvagge oltre lo steccato -lettere a mia figlia per far casa sul pianeta ” (Exòrma 2023).
Se appena riuscite, non perdetevi Bayo che è uno dei trickster più gentilmente animati e capace di spiazzare intrecciando visioni che abbia mai conosciuto.